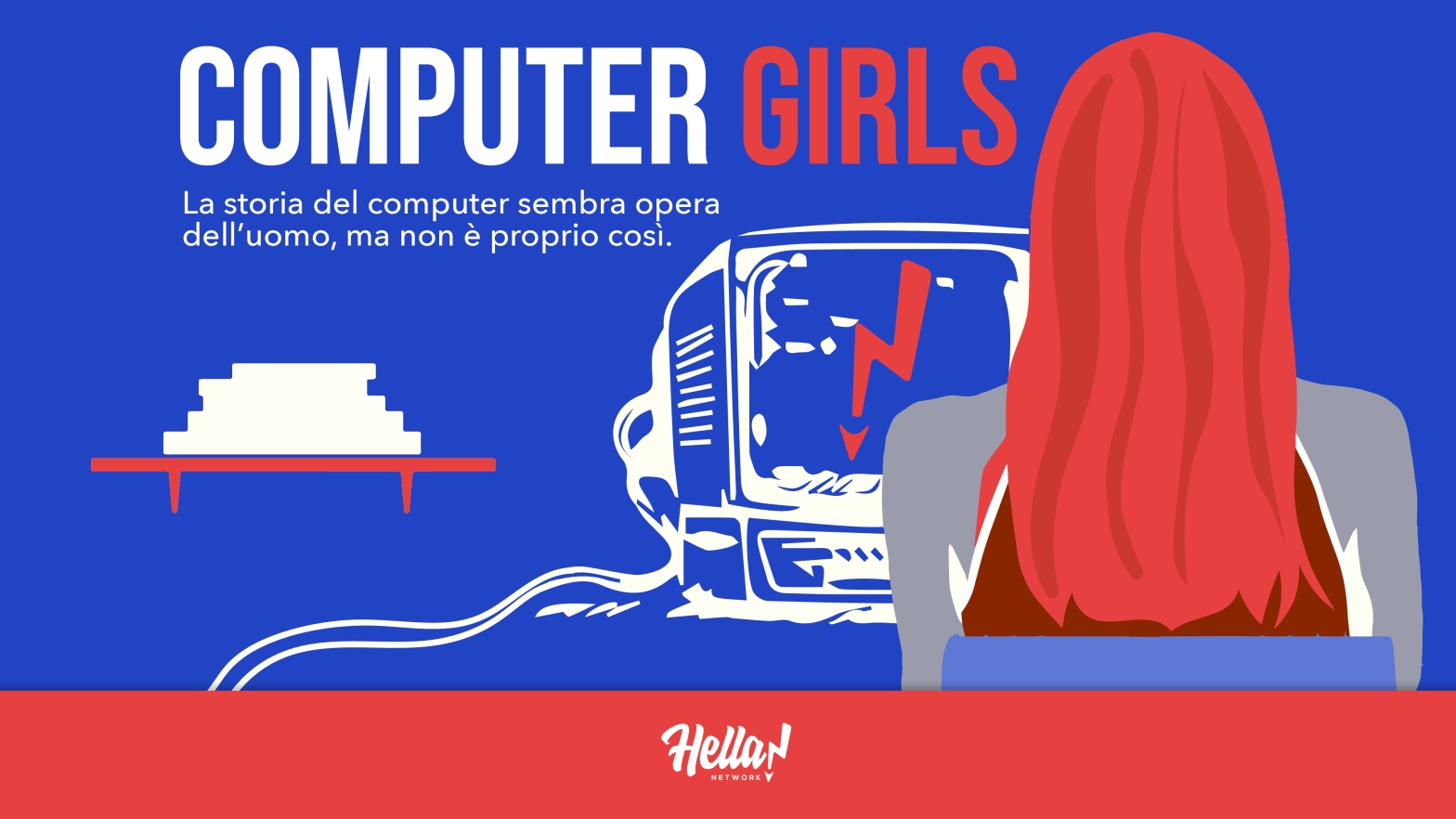Qualche anno fa ho fatto parte di un’organizzazione internazionale che rappresenta un movimento consapevole di persone unite dall’obiettivo di poter superare, entro il 2030, la povertà estrema (che colpisce chi vive con meno di 1,9$ al giorno) e le malattie facilmente prevenibili. Durante questa esperienza ho vissuto esperienze memorabili, come testimonia un mio selfie con Bill Gates, e imparato tantissimo sulle disuguaglianze che prevengono le pari opportunità. In particolare, il report Poverty is sexist – La povertà è sessista, che abbiamo pubblicato, studiato e promosso, dimostra quanto per una donna sia più probabile diventare o restare povera.
L’impatto del genere sulle disuguaglianze economiche, di accesso alla salute, all’educazione, alla nutrizione e alla partecipazione al processo decisionale è particolarmente severo in alcuni Paesi in via di Sviluppo e in altri definiti “fragili” dalla Banca Mondiale, ma non è estraneo al nostro mondo occidentale e ritenuto sviluppato in cui viviamo.
In questo nuovo articolo di Periodica tratteremo infatti una tipologia di disuguaglianza che colpisce in modo specifico e sistematico una parte della popolazione, in funzione di una caratteristica nel funzionamento del corpo: il ciclo mestruale. Parliamo della cosiddetta Period Poverty, la povertà collegata alle mestruazioni, che si concretizza non solo in una difficoltà di acquisto di dispositivi di igiene mestruale (assorbenti, tamponi, coppette, etc), ma anche nella difficoltà o impossibilità di accedere a luoghi sicuri e adatti in cui potersi occupare della propria igiene e a informazioni appropriate sul ciclo mestruale e il suo funzionamento (più in generale, a un’adeguata educazione sessuale).
Le sfide causate dalla Period Poverty si manifestano con gradi e livelli differenti a seconda della zona e cultura in cui ci si trova. Generalmente, nei Paesi ad alto reddito le difficoltà sono economiche in relazione all’acquisto di prodotti per il ciclo mestruale, mentre nei Paesi a medio o basso reddito le problematiche sono legate alla più ampia gestione dell’igiene mestruale. A prescindere dal contesto il risultato però non cambia: chiunque abbia le mestruazioni rischia di trovarsi a vivere situazioni discriminanti e penalizzanti.
PERIOD POVERTY IN PAESI A MEDIO/BASSO REDDITO
Nei Paesi in via di sviluppo, circa 2,4 miliardi di persone vivono senza accesso ai servizi sanitari di base, e solo il 27% della popolazione mondiale dispone di strutture per lavarsi le mani. Queste condizioni igieniche aumentano la vulnerabilità a crisi sanitarie – come quella legata al virus Cov-19 – che a loro volta, per la natura urgente della loro comparsa, rallentano i regolari interventi di sanità pubblica dedicati allo sviluppo di un’adeguata assistenza sanitaria, a un’educazione regolare e generica verso le buone pratiche igieniche. Come è purtroppo facile immaginare, a farne le spese sono soprattutto le misure dedicate alla gestione dell’igiene mestruale.
Come abbiamo visto nel primo articolo di Periodica, le mestruazioni sono un tabù; non parlarne ha impatti sull’inclusione delle esigenze di chi le ha all’interno dell’agenda pubblica. Questo silenzio è rinforzato dalla natura patriarcale dei sistemi in cui viviamo, con conseguenti implicazioni sulla concretizzazione dei diritti umani di donne e ragazze, in particolare il diritto alla salute, all’istruzione e al lavoro.
È così che, secondo The Hygiene and Health Report 2020-21, circa il 42% della popolazione mondiale non ha frequentato la scuola o il lavoro per tematiche igieniche legate alle mestruazioni. Il primato negativo spetta all’India, in cui tale percentuale sale al 77%, ma riporta per l’Italia un preoccupante 40%. In 3 casi su 10 la motivazione ha a che fare con la mancanza di accesso a strutture igieniche pulite e/o sicure.
Considerando invece la capacità di spesa per l’acquisto di prodotti per l’igiene mestruale, circa 500 milioni di persone sperimentano la Period Poverty ogni mese, dovendo scegliere tra assorbenti/tamponi etc e beni di esigenza primaria, tra i quali il cibo. Per citare un esempio, in Kenya questa condizione affligge il 65% di chi ha le mestruazioni. Allargando lo sguardo, circa 1 persona su 10 nel mondo si è trovata nelle condizioni di non potersi permettere prodotti per l’igiene mestruale.
Quando, per ragioni economiche, igieniche o sociali, non si utilizzano adeguati prodotti per l’igiene mestruale, si ricorre a soluzioni di fortuna perlopiù inefficienti, ma soprattutto pericolose per la salute. Prodotti come stracci, tovaglioli di carta e assorbenti riutilizzati generano rischi di infezioni urogenitali, anche gravi. È inoltre dimostrato che l’impatto di questa dimensione della Period Poverty sia correlata a elevati livelli di ansia, depressione e angoscia.
Risulta quindi evidente che la Period Poverty vada ben oltre una semplice questione economica, e che sia un argomento complesso e strettamente legato alla cultura e allo stigma legato alle mestruazioni. Sarebbe pertanto ingenuo pensare che sia sufficiente distribuire prodotti gratuiti alle fasce più vulnerabili della popolazione per risolvere il problema.
Ne è dimostrazione un esperimento condotto in Uganda in cui, per incentivare la frequenza scolastica, sono stati distribuiti gratuitamente assorbenti lavabili e usa e getta alle studentesse. Nonostante le ottime premesse, il tasso di frequenza scolastica non è aumentato. In alcuni casi le studentesse non avevano idea di come utilizzare i prodotti ricevuti e avevano troppa vergogna delle proprie mestruazioni per chiedere suggerimenti. Nel caso di assorbenti lavabili, l’imbarazzo di stenderli ad asciugare portava le studentesse a non lavarli, con conseguenti fastidi che rendevano insopportabili le giornate sedute sui banchi. In altri casi ancora i compagni di scuola, intravedendo sotto gli abiti delle compagne gli assorbenti, le prendevano in giro, spingendole ancora una volta a rinunciare ad andare a scuola. A partire da questa evidenza è stato sviluppato un nuovo progetto in cui rappresentantə delle comunità locali, in collaborazione con un gruppo di ricercatorə e professionistə, hanno accolto la sfida di provare a superare quei tabù che impediscono di gestire le mestruazioni con dignità tramite proposte concrete e sostenibili. Il progetto ha avuto successo grazie al cambio di paradigma: non solo predisporre l’accesso a una gamma di prodotti mestruali a prezzi accessibili realizzati a livello locale ma educare uomini, donne, ragazzi e ragazze sulle mestruazioni.
Per superare la Period Poverty nei Paesi a medio o basso reddito, è dunque fondamentale:
- Lavorare su una cultura che rifiuti i tabù e i preconcetti legati alle mestruazioni;
- Promuovere educazione e consapevolezza del funzionamento del corpo durante le mestruazioni e dei prodotti che permettano di gestirle al meglio;
- Sviluppare spazi e soluzioni dedicate all’igiene mestruale adeguate in linea con il protocollo WASH (Water, Sanitation and Hygiene) nelle scuole e nei luoghi pubblici;
- Rendere accessibili i prodotti per la gestione dell’igiene mestruale.
Solo così sarà possibile rendere le mestruazioni un diritto umano fondamentale e non un elemento di discriminazione, così come previsto dalla Women’s Convention, secondo cui
“Le pratiche relative alle mestruazioni possono costituire una discriminazione se influenzano le libertà fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale e civile o qualsiasi altro campo.”
PERIOD POVERTY NEI PAESI AD ALTO REDDITO.
L’impatto delle Period Poverty nei Paesi a più alto reddito è connesso alla dimensione economica che impedisce ad alcune fasce della popolazione di acquistare prodotti per l’igiene mestruale o di poter scegliere alternative migliori rispetto a quelle di fascia di prezzo e qualità inferiori.
In Italia, ad esempio, la spesa annuale per assorbenti o tamponi è di circa 90€ per ogni membro del nucleo familiare che abbia le mestruazioni; considerando in media 40 anni di mestruazioni, l’impatto economico raggiunge 3600€ nel corso della vita, senza considerare il costo per tutti gli altri prodotti che orbitano attorno al ciclo mestruale femminile come antidolorifici, prodotti cosmetici e contraccettivi ormonali.
È fondamentale analizzare le caratteristiche di questa spesa: si tratta di una spesa necessaria e non accessoria e che ricade principalmente sulle donne, che, come sappiamo, hanno un potere d’acquisto inferiore, determinato da livelli occupazionali inferiori rispetto agli uomini e da un gender pay gap ancora troppo rilevante. La crisi causata dalla pandemia inoltre ha evidenziato il fenomeno della “SheCession”, una recessione che ha colpito con maggior forza le donne. Secondo l’Istat oggi sono 2 milioni e 472 mila le donne in Italia che vivono in condizione di povertà assoluta e che faticano a permettersi l’acquisto di prodotti per la gestione dell’igiene mestruale.
In questo contesto risulta chiaro che il costo delle mestruazioni diventi estremamente discriminante e debba essere incluso nella conversazione politica.
Un altro tema fortemente discusso è quello della Tampon Tax, riferito all’esistenza di tassazioni specifiche sui prodotti per l’igiene mestruale che li equiparano a prodotti considerati non necessari.
Nel 2006, l’Unione Europea ha previsto che i prodotti “di protezione dell’igiene femminile” possano essere assoggettati ad aliquote ridotte. Alcuni Paesi hanno dato seguito a questa indicazione riducendo l’IVA su assorbenti e tamponi: al 7% in Germania, al 5,5% in Francia, al 3% in Lussemburgo. Altri Paesi hanno deciso di cancellare completamente la Tampon Tax, tra questi il Regno Unito, in risposta a una situazione di Period Poverty molto accentuata che vede, secondo una ricerca di Plan International UK, il 42% delle intervistate utilizzare soluzioni come calzini o carta di giornale per far fronte al proprio flusso mestruale. A livello globale anche Canada, Kenya, India e Australia hanno abolito la Tampon Tax.
La situazione è ancora molto arretrata in Italia. Benché l’IVA riservata ai beni di prima necessità sia del 4%, i prodotti per l’igiene mestruale non sono considerati tali, e sono di conseguenza sottoposti ad aliquota ordinaria del 22%. A dicembre 2019, l’IVA per assorbenti/tamponi biodegradabili e compostabili è stata ridotta al 5%, misura non ancora soddisfacente poiché questa tipologia di prodotto è ancora troppo costosa e difficile da reperire.
Secondo una ricerca italiana (AstroRicerche, 2019), il 45,5% delle donne conosce l’esistenza di questa tassa, rispetto al 31,5% degli uomini, e nel 63,0% ritiene inaccettabile che gli assorbenti siano tassati come un bene di lusso dal momento che rappresentano un bene di prima necessità.
Il The Hygiene and Health Report 2020-21 riporta che il 47% dei rispondenti considera che fornire in modo gratuito prodotti per l’assorbenza a persone che vivono condizioni di povertà sia una misura concreta per migliorare la salute mestruale; il 43% ritiene che la Tampon Tax debba essere rimossa.
Non soltanto la dinamica di prezzo e tassazione, ma anche la questione dell’accesso a prodotti per la gestione mestruale in ambienti pubblici è estremamente contingente. Secondo la ricerca realizzata dalla no profit statunitense Free the Tampons, l’86% delle donne americane si è trovata a dover gestire l’arrivo inatteso delle mestruazioni in luoghi pubblici senza disporre dei prodotti necessari. Nel 79% dei casi, la soluzione è stata quella di improvvisare un assorbente con carta igienica o simili, causando disagio (57%), ansia (43%) e addirittura panico (35%). Per favorire il benessere fisico ed emotivo di chi ha le mestruazioni è importante prevedere la presenza di distributori di assorbenti e tamponi nei luoghi pubblici, possibilmente a prezzi calmierati o gratuiti, così da non escludere nessuna persona che ne abbia necessità.
In quest’ottica, è esemplare la scelta della Scozia che, con il “Period Products Bill” del 2020, ha approvato la prima legge dedicata al contrasto della Period Poverty tramite la distribuzione gratuita di prodotti dedicati all’assorbenza mestruale nelle scuole e nelle università, unita a misure di informazione e sensibilizzazione mirate a eradicare lo stigma legato alle mestruazioni. Anche la Nuova Zelanda, guidata dalla prima ministra Jacinda Ardern, ha previsto di fornire prodotti per l’igiene mestruale in modo gratuito; speriamo che molti altri Paesi seguano questi esempi.
È inoltre fondamentale assicurare che l’accesso universale a questi prodotti e a luoghi sicuri per poter gestire le proprie mestruazioni. Non tutte le donne hanno le mestruazioni, non tutte le persone che hanno le mestruazioni sono donne e purtroppo la Period Poverty tende a colpire maggiormente chi fa parte di gruppi marginalizzati. Lo stigma associato alle mestruazioni coinvolge anche persone non binarie e transgender. L’esperienza non è inclusiva in tutti quei casi in cui vengono proposti unicamente prodotti per l’assorbenza basati sull’inserimento, quando i bagni sono differenziati in base al genere e quando non hanno contenitori per lo smaltimento dei prodotti mestruali, e anche in quei casi in cui, pur essendo disponibili gratuitamente, vadano richiesti a una persona terza, come ad esempio un insegnante.
CONCLUSIONI
Superare la Period Poverty fa parte di una più ampia occasione per raggiungere la parità di genere, perché con mestruazioni che non siano più limitanti si garantisce accesso e partecipazione a un numero sempre maggiore di persone alle attività sociali ed economiche. Il beneficio che ne deriva, inoltre, non avvantaggia solo chi ha le mestruazioni, bensì, grazie alla loro acquisita capacità di reinvestire i guadagni nelle loro famiglie e comunità, si favorisce un aumento di valore per tutta la società, costruendo capitale umano che alimenterà la futura crescita economica.
L’accesso ai prodotti per l’igiene mestruale è un diritto, e sentirsi pulitə, sicurə e nelle condizioni di poter portare avanti la propria quotidianità durante le mestruazioni è una necessità.
Ci sono moltissimi modi in cui possiamo contribuire al raggiungimento di una società che consideri le mestruazioni come un elemento naturale e non discriminante:
- Innanzitutto, informarci e parlarne. Lo diciamo sempre su Periodica, ma questo è davvero il primo e più efficace strumento per scardinare lo stigma. Facciamolo in persona, sui social media, con le persone più e meno giovani, e non dimentichiamoci di parlarne anche con gli uomini, il raggiungimento di un’equità mestruale è anche affar loro.
- Contattare i nostri rappresentati locali e nazionali e chiedere che le tematiche legate alle mestruazioni vengano incluse nella conversazione politica. La nostra voce può contribuire a raggiungere una riduzione della Tampon Tax e/o distribuzione gratuita di prodotti dedicati alle mestruazioni, così come un’adeguata educazione nelle scuole.
- Richiedere alle persone responsabili delle nostre scuole, università, uffici di considerare la possibilità di prevedere dei distributori di assorbenti/tamponi nei bagni di e per tuttə coloro che possano averne necessità, e di assicurarsi che le condizioni igieniche e di sicurezza siano sufficienti.
- Sostenere chi vive mestruazioni più complesse delle nostre.
Queste sono alcune idee, ma cogliamo l’occasione di creare una comunità consapevole che contribuisca a un nuovo ciclo di cambiamento positivo in cui le mestruazioni e i prodotti a esse legate possano essere accessibili, sicuri e senza stigma.
Articolo di Martina Palmese, immagine di Alessandra D’Amico.